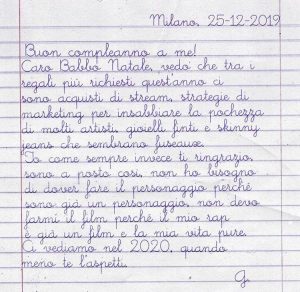Un ragazzino nato in Slesia nel 1916, in piena Prima guerra mondiale, affronta la sua infanzia con paure, timori e insicurezze gravi che non gli permettono di vivere come qualsiasi coetaneo. Lui è Hans Ulrich Rudel, colui che diventerà il pilota tedesco più decorato della Seconda Guerra Mondiale.
 Buona parte delle sue insicurezze svaniscono attorno ai 13 anni, ma è ormai destinato da una madre severa e un padre pastore protestante a frequentare un liceo umanistico della zona. E lì incontra altri problemi: in primo luogo un andamento scolastico a malapena sufficiente. La vita agrodolce dell’adolescente continua fino a che le sue sorelle gli raccontano di aver assistito a una importante manifestazione aerea con incluso il lancio di alcuni paracadutisti. Proprio questa storia trasmette un immenso desiderio di diventare pilota a Hans Ulrich.
Buona parte delle sue insicurezze svaniscono attorno ai 13 anni, ma è ormai destinato da una madre severa e un padre pastore protestante a frequentare un liceo umanistico della zona. E lì incontra altri problemi: in primo luogo un andamento scolastico a malapena sufficiente. La vita agrodolce dell’adolescente continua fino a che le sue sorelle gli raccontano di aver assistito a una importante manifestazione aerea con incluso il lancio di alcuni paracadutisti. Proprio questa storia trasmette un immenso desiderio di diventare pilota a Hans Ulrich.
Nel 1936, la neonata aeronautica militare tedesca, la celebre Luftwaffe di Hermann Göring, indice un concorso per diventare aviatori in varie località della Germania. Hans, però, deve passare la graduatoria con un numero ristretto di futuri allievi. Lui con un pizzico di fortuna dopo il concorso viene ammesso e viene trasferito nell’estate stessa di quell’anno in una scuola di volo a Potsdam, vicino a Berlino. Nel campo di aviazione egli impara a volare per diventare futuro pilota militare e più esattamente, secondo il suo sogno, pilota di caccia. Purtroppo per lui, però, durante la cerimonia di assegnazione del ruolo, gli viene invece affidato con sua profonda delusione il compito di pilota ricognitore.
Hans incontra di nuovo i fantasmi del suo passato, le sue insicurezze, ma finalmente riesce a riprendere il controllo di sé e continua sul percorso affidatogli. Prima dell’invasione della Polonia a Ulrich viene assegnata la versione B del bombardiere da picchiata Junkers-87 “Stuka”, conosciuto per il suono terrificante che emette durante la fase di picchiata per impaurire il nemico a terra. Nella squadriglia del giovane pilota, questi velivoli vengono utilizzati per tutta la campagna come velivoli da ricognizione, costringendo Hans a fare missioni “noiose” rispetto al ruolo principale dello “Stuka”.
I superiori di Rudel sono molto diffidenti nei suoi confronti, ma nel giugno del 1941, quando inizia l’Operazione Barbarossa, lui inizia a dimostrare di avere qualche talento, distruggendo una discreta quantità di obiettivi mobili terrestri. Nelle settimane successive, durante la ritirata dell’Esercito Rosso verso la profonda Russia europea, il pilota inizia a distruggere un numero considerevole di carri armati T-34 e BT-7, iniziando così a farsi notare dai suoi diffidenti superiori, i quali capiscono che si stavano sbagliando.
Affiancandosi a un nuovo capo-stormo, affronta altre missioni e, durante un temporale improvviso, il Junkers del superiore, Steen, tocca l’ala di Rudel, cosa che gli fa perdere il controllo facendolo dirigere verso il culmine del mal tempo. Con grande freddezza l’abile Hans riesce a riprendere il controllo all’ultimo istante, tornando alla base con un ala perforata e un timone letteralmente staccato. Nel settembre del ’41 il suo stormo viene impiegato per un attacco navale nel Mar Baltico, a venti chilometri da Leningrado: lui e i suoi compagni si buttano in picchiata da cinquemila metri di quota verso un’intera flotta di navi sovietiche armate con un totale di 600 cannoni antiaerei. Tra queste imbarcazioni ci sono le note corazzate Marat e Rivoluzione d’Ottobre accompagnate dagli incrociatori pesanti Massimo Gorki e Kirov. Lui si butta come un kamikaze sulla Marat fino ad arrivare a una quota spericolata di 300 metri, dove un velivolo dovrebbe essere già stato disintegrato dall’artiglieria antiaerea. Hans sgancia la sua bomba di mille chili facendo così affondare la corazzata, della stazza di mille e trecento tonnellate. Nella successiva missione riesce a distruggere un incrociatore e un cacciatorpediniere.
A fine anno ha già con sé la Croce di Ferro di seconda e prima classe e la Croce Tedesca in oro, essendo pure conosciuto nella Luftwaffe come un valoroso e spericolato pilota. Nel 1942, dopo mesi di annientamenti di blindati, cannoni e carri nemici, raggiunge le mille missioni di carriera, durante le quali viene anche abbattuto una decina di volte da caccia nemici o artiglierie antiaeree. Il pilota, nonostante questi incidenti, riesce a ritornare operativo con ferite poco gravi, anche se nel 1942 viene fermato da alcune forme d’itterizia, ovvero sintomi di malattia del fegato. Ma pure questa volta riesce a superare l’ostacolo, disobbedendo ai consigli dei medici di ritirarsi.
A fine anno viene assegnato al fronte di Stalingrado con la versione avanzata dello Stuka, il G-2 Kannonenvogel, armato con cannoni automatici calibro 37 mm. Con il nuovo apparecchio, aumenta la sua lista di obiettivi terrestri distrutti. Diviene capo squadriglia nel 1943 fino alla fine della guerra, volando in poche missioni anche con il cacciabombardiere Focke Wulf 190. Durante l’ultimo triennio di guerra riesce anche ad abbattere 11 aerei sovietici, tra cui nove aerei d’attacco Il-2 Sturmovik e due caccia Lagg-3. Rudel riceve anche, tra i pochi militari tedeschi del conflitto mondiale, la prestigiosa onorificenza di Cavaliere della Croce di Ferro con fronde di Quercia in oro, spade e diamanti, conferitagli a gennaio del 1945 direttamente da Adolf Hitler, che nella stessa occasione lo promuove colonnello; a quella si aggiungono anche le decorazioni non tedesche, come la medaglia d’argento al valore militare italiana e quella al coraggio ungherese.
A fine guerra Ulrich viene abbattuto dalla contraerea, costringendolo a farsi amputare la gamba destra a causa dei frammenti di proiettili. Il pilota non si ferma e, dopo un mese di recupero, spicca di nuovo il volo fino ad arrendersi agli americani nel maggio 1945. Lui, e insieme i suoi amici assi della Luftwaffe, vengono subito circondati da soldati anglo-americani incuriositi di vedere di persona questi grandi e spietati aviatori rispettati talmente tanto dai nemici di guerra, che persino dopo il conflitto l’asso dell’aviazione inglese Bader (a sua volta privo di due arti) aiuta Hans a farsi operare in Inghilterra per problemi postumi dell’amputazione.
Non essendo stato un pilota di caccia, non è considerato nella lista dei migliori assi dell’aviazione tedesca, ma molti lo considerano come uno tra i migliori aviatori militari della storia ed è stato soprannominato Pilota di Ferro. Le sue azioni spericolate e il carattere forte, temprato dalle difficoltà, come accennato portano Hans Ulrich Rudel anche a essere il soldato tedesco più decorato nel secondo conflitto mondiale. Alle sue spalle si porta anche ben 2500 missioni di volo, con 512 carri armati, 800 obiettivi mobili, 150 cannoni di artiglieria e contraerea, 73 tra navi e imbarcazioni e infine 11 aerei nemici distrutti. Il Pilota di Ferro si trasferirà in Argentina, dove vivrà fino alla fine degli anni Settanta, ritornando poi nell’allora Germania Ovest. Morirà nel 1982 a causa di un ictus, all’età di 66 anni.
Alberto Julio Grassi, 3 A Scientifico