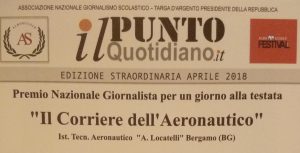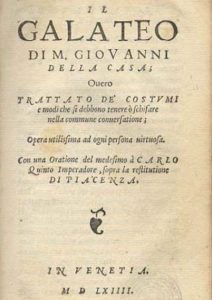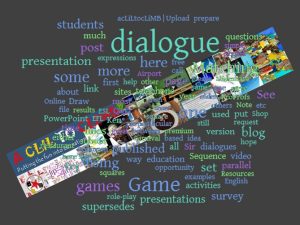La storia inizia nel primi anni del 1900. Siamo in val di Scalve, nell’alta bergamasca: nel 1907 l’ingegner Tosana di Brescia chiede il permesso per lo sfruttamento dell’acqua del torrente Povo. Più tardi il permesso verrà concesso all’ingegner Gmur e quindi alla ditta Galeazzo Viganò, da Truggio, in provincia di Milano. È una ditta tessile e per questo ha molto bisogno di energia elettrica. Il progetto consiste in una diga a gravità costruita in località Pian del Gleno: uno sbarramento verticale che si oppone alla forza dell’acqua grazie al suo peso, la diga del Gleno.
 Nel 1917 la ditta Viganò inizia i lavori di costruzione della diga anche se il progetto non è ancora stato approvato dal Genio Civile, e appalta i lavori di costruzione della diga a una ditta di Milano. Gli operai sono pagati a cottimo perciò lavorano velocemente e male. Abbiamo testimonianze di persone che hanno visto con i loro occhi che i ferri usati erano vecchi e alcuni provenivano, si dice, dalla prima guerra mondiale.
Nel 1917 la ditta Viganò inizia i lavori di costruzione della diga anche se il progetto non è ancora stato approvato dal Genio Civile, e appalta i lavori di costruzione della diga a una ditta di Milano. Gli operai sono pagati a cottimo perciò lavorano velocemente e male. Abbiamo testimonianze di persone che hanno visto con i loro occhi che i ferri usati erano vecchi e alcuni provenivano, si dice, dalla prima guerra mondiale.
Una donna di Corna, uno dei paesi distrutti dall’acqua, ha detto che il padre le intimava di scappare perché in Val di Scalve girava la voce che la diga che si stava costruendo sarebbe crollata e che quindi avrebbe travolto i paesi sottostanti. Nel 1921 il progetto viene cambiato: sopra la base della diga a gravità, sarebbe stata costruita una diga ad archi multipli.
All’epoca la diga ad archi multipli era una novità. Era appena terminata la costruzione di una diga di questo tipo in Sardegna e, per essere al passo con le innovazioni, si decide di seguire il loro esempio.
Il cambio di progetto è, probabilmente, uno degli eventi scatenanti la caduta dello sbarramento. Se il progetto non avesse subito variazioni forse la diga non sarebbe caduta. Gli archi multipli vengono “appoggiati” alla base della diga senza fissarli adeguatamente. I lavori continuano fino all’ottobre del 1923, quando la diga è riempita per la prima volta in seguito a precipitazioni. Il brutto tempo prosegue fino a metà novembre, quando si registrano fuoriuscite di acqua dallo sbarramento. Il primo dicembre alle 6,30 il guardiano della diga, Morzenti, sente forti rumori ed esce per controllare cosa sta accadendo. Alza gli occhi e si vede i pezzi di diga cadere addosso. Allora scappa verso la montagna.
Alle 7,15 i dieci archi centrali della diga crollano portando con sé dai 5 ai 6 milioni di metri cubi d’acqua. Il primo paese che l’acqua raggiunge è Bueggio, dove vengono distrutte la chiesa e alcune case. Poi tocca a Dezzo, un paese diviso a metà dal corso del fiume omonimo. Le case sulla riva sinistra sono rase al suolo, mentre la parte a destra del fiume si salva per la presenza di un grande masso che devia il corso dell’acqua.
La val di Scalve è unita alla val Camonica dalla via Mala, una strada in alcuni tratti a strapiombo sul fiume. Questa via viene totalmente distrutta dall’acqua che scende a valle, perciò per molti giorni sarà impossibile raggiungere la val di Scalve dalla provincia di Brescia. Dopo la via Mala si trova il paese di Angolo Terme, dove però non ci sono danni, a parte la distruzione del ponte principale.
Si registrano morti a Mazzunno, ora frazione di Angolo Terme, ma che a quel tempo era comune a sé. Qui l’acqua distrugge la centrale idroelettrica, che in seguito è stata ricostruita ed è ancora funzionante. Sulle rive del fiume c’è il cimitero di Mazzunno, l’acqua lo abbatte e porta con sé i cadaveri. I mazzunnesi che erano presenti hanno raccontato che quando l’acqua si è calmata i cadaveri galleggiavano sui laghi che si erano formati.
Dopo Mazzunno c’è Gorzone, una frazione di Boario, dove però non si registrano danni. A Gorzone l’acqua è frenata da alcune rocce che ostruiscono il passaggio, così quando riesce a passare riacquista una notevole velocità. Proprio per questo quando l’acqua raggiunge Corna, il paese più popolato di questa triste storia, rade al suolo tutto quello che trova sulla sua strada.
Solo a questo punto l’acqua si calma, raggiunge il lago d’Iseo e lascia dietro di sé circa 360 morti accertati (ma alcune stime superano i 500) e molti feriti.
A seguito di questa catastrofe il re Vittorio Emanuele II, visita Boario, vicino a Corna, e Dezzo, per manifestare cordoglio ai sopravvissuti e vedere con i suoi occhi la distruzione. Il 2 dicembre anche Gabriele d’Annunzio visita i due paesi, a cui dona una somma di denaro non indifferente. Viene avviata un’inchiesta per capire di chi sia la colpa del crollo: viene imputato Virgilio Viganò, che dirigeva i lavori alla diga. Muore prima di andare in carcere. Durante il processo emerge che la causa principale del crollo è che gli operai riempivano la costruzione con materiali scadenti. È contato molto anche il cambio di progetto, non adatto.
Dove una volta c’era il bacino della diga, ora c’è un laghetto bellissimo, diventato meta turistica. Tante famiglie portano i figli ad ammirare la maestosità dei resti della diga e a raccontare loro un pezzo di storia locale. Io abito ad Angolo Terme, un paesino che ha vissuto in prima persona la tragedia della caduta della diga del Gleno. Credo che sia importante conoscere la storia per fare in modo che nessuno più commetta gli stessi errori.
Viola Ghitti, 1 A Scientifico