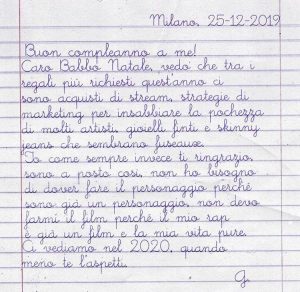di Gioele Valesini, Liceo Quadriennale
 PROLOGO – Molte persone dicono che con l’età la memoria piano piano si affievolisce, eppure anche se sono passati tanti anni quando chiudo gli occhi le immagini mi sovvengono alla mente, nitide come se fosse passata appena qualche luna invece degli innumerevoli inverni trascorsi da quegli avvenimenti. I primi ricordi che ho sono i migliori: campi rigogliosi, piccole casupole di legno, lo scorrere sinuoso di un piccolo torrente lungo la pianura e bambini che si rincorrono, si nascondono e a volte giocano a fare i soldati ma senza ferirsi e sempre pronti ad aiutarsi anche tra schieramenti opposti.
PROLOGO – Molte persone dicono che con l’età la memoria piano piano si affievolisce, eppure anche se sono passati tanti anni quando chiudo gli occhi le immagini mi sovvengono alla mente, nitide come se fosse passata appena qualche luna invece degli innumerevoli inverni trascorsi da quegli avvenimenti. I primi ricordi che ho sono i migliori: campi rigogliosi, piccole casupole di legno, lo scorrere sinuoso di un piccolo torrente lungo la pianura e bambini che si rincorrono, si nascondono e a volte giocano a fare i soldati ma senza ferirsi e sempre pronti ad aiutarsi anche tra schieramenti opposti.
Però vi sono notti in cui queste visioni si oscurano fino a sparire, per essere rimpiazzate dagli incubi, visioni oscure, piene di sangue e fiamme. Immagini di un demone vestito di ferro, gli occhi due fessure che sbucano dall’elmo insanguinato mentre intorno a lui le fiamme divampano, uomini corrono, urlano, invocano pietà e muoiono. E in tutto questo l’essere rimane indifferente, fermo in mezzo alla devastazione con la lancia stretta in pugno, lo scudo a terra e la corazza schizzata del sangue degli innocenti che hanno osato pararsi davanti alla furia omicida di cui il demone è in balia.
Ma quando finalmente il demone, sporco e insanguinato, si volta e rivela la sua vera identità mi sento trascinato verso il basso come se il terreno mi inghiottisse e mi sveglio, avvolto nelle coperte inzuppate di sudore. Questa è una di quelle notti, ma ora che sono vicino al tramonto della mia vita ho deciso di affrontare per l’ultima volta i miei demoni di modo da potermene andare da questo mondo a cuor leggero, senza alcun rimpianto per ciò che ho fatto nel corso della mia lunga vita.
Scendo dal pagliericcio e mi dirigo alla cucina, i miei passi rimbombano per le stanze vuote della casa e riescono quasi a oscurare il rumore delle pulsazioni accelerate del mio cuore. Mentre mi avvicino alla porta piccole gocce di sudore mi scorrono lungo la fronte, ma ormai ho deciso: questa notte non mi arrenderò. Apro la porta e mi reco in riva al piccolo torrente che scorre lungo il fianco della collina.
L’ultima volta che venni qui i miei capelli erano ancora lunghi e fluenti e le mie membra erano permeate dalla forza della gioventù mentre ora le mie povere braccia raggrinzite fanno fatica a sollevare la grossa pietra sull’argine del fiume. Dopo innumerevoli tentativi però sono finalmente riuscito a scostare la roccia e a riportare alla luce il nascondiglio della mia vergogna e del mio passato.
Questo è l’atto finale, dopo oggi non rivedrò mai più questo paesaggio che mi fu così caro nella mia gioventù, ma nemmeno rivivrò di nuovo le notti di incubi.
Le mani mi tremano mentre allungo le braccia verso la sacca di tela posta in fondo alla fossa, ma mi costringo a prenderla e la sollevo fino a estrarla dalla buca in cui è giaciuta per molti anni, la adagio sull’erba verde dei prati che circondano la mia piccola casa.
Il cuore mi batte all’impazzata mentre infilo la mano nella sacca e la rivolto, portandone all’esterno il contenuto. Gli occhi mi si riempiono di lacrime e faccio fatica a controllarmi e a non fuggire lontano da ciò che per una qualsiasi persona potrebbe essere motivo di rispetto, ma che per me è l’incarnazione del terrore. Mi costringo a guardare gli oggetti del mio passato. Ed eccolo, adagiato sul campo, il mio vecchio equipaggiamento da oplita.
Tutto sembra nuovo come quando mi venne consegnato nel giorno maledetto in cui il mio destino cambiò. Il mio elmo sormontato dalla lunga cresta rossa, la thoprax di lucido bronzo che in molte occasioni mi salvò la vita, la spada acuminata causa del lamento di innumerevoli mogli e figli, ma soprattutto l’oplon, il simbolo della gloria degli opliti, per me diventato ormai un marchio di vergogna.
Il grande scudo decorato dall’immagine dell’elmo nero in campo rosso, simbolo della mia unità di appartenenza, sembra scrutarmi l’anima e all’improvviso mi ritornano alla mente i molti uomini che vi si sono gettati contro per poi perire. Gli oggetti che per molti anni furono testimoni della mia vergogna sono ancora lucidi e integri, come se le innumerevoli stagioni trascorse da quel giorno d’estate in cui furono nascosti dalla luce del giorno non avessero peso su di loro come ce l’hanno su di me. I ricordi mi tornano alla mente e stavolta non riesco, non voglio respingerli, e dunque ecco che vengo trasportato di nuovo nei luoghi della mia infanzia.
Capitolo 1, Tebe, 27 anni prima (segue dal n° precedente)
I tiepidi raggi del sole filtrano attraverso la piccola finestra della casa, gli uccelli fanno capolino dai loro nidi tra le alte fronde degli alberi riempiendo l’aria con i loro canti mentre la brezza primaverile corre sulle colline seguendo il corso del ruscello fino ad arrivare a accarezzarmi delicatamente la pelle. Apro lentamente gli occhi e intorno a me vedo gli stessi oggetti che hanno decorato questa casa per tutti i 20 anni che vi ho passato, senza mai cambiare posizione quasi fossero delle colonne che reggono la struttura e le permettono di rimanere in piedi e forse è così; d’altronde senza i ricordi correlati ad essi questa sarebbe solo una casa come mille altre. Il suono della porta che si apre e un gran numero di espressioni colorite mi distolgono dalle mie riflessioni. Giro la testa e guardò sorridendo l’imponente figura che si staglia sull’ingresso.
“Buongiorno Timoteo” dico con voce melliflua, “a cosa devo questo caloroso risveglio?”
“Risparmiati l’ironia Alexis, sappi che è stata un’impresa degna di Eracle strappare tutte le erbacce da solo.”
Mentre lui mi parla ancora una volta osservo la sua figura imponente. Il mio sguardo corre dalle sue gambe per tutta la lunghezza del suo corpo fino ad arrivare al suo viso. Quel volto che ormai era familiare quanto il veder sorgere e tramontare il sole e che sembrava quasi una statua con quei lineamenti rettilinei, apparentemente privi di qualsiasi curvatura, la fronte prominente, il naso aquilino, la barba ormai grigia portata corta che incornicia una mascella squadrata, perfino le rughe sembravano perfettamente dritte e parallele tra loro. E in mezzo a questa scultura vi erano due occhi di ossidiana, profondi e attenti, che scrutano tutto ciò che li circonda tenendolo sotto controllo, come se si aspettassero che da un momento all’altro qualcosa potesse aggredirli.
“Beh hai finito di osservarmi come se fossi Febo Apollo che balla con una capra? C’è tua madre qua fuori che vuole parlarti”
“Mia madre?”
“È quello che ho detto no? O hai due madri e non me lo hai mai detto?”
Mi alzo in piedi e vado rapidamente verso l’angolo della stanza dove appeso a un gancio alla parete sta il mio chitone rosso. Lo indosso in fretta e furia e esco di corsa dal casolare. Intorno a me vedo le verdi colline piene dei fiori appena spuntati grazie al ritorno del sole primaverile dopo il lungo e freddo inverno, intorno ad esse i campi di grano ondeggiante mentre viene accarezzato dal vento primaverile mentre i contadini escono dalle case e si dirigono verso di essi per iniziare la loro dura giornata di lavoro. E sullo sfondo di questo paesaggio le mura bianche della città di Tebe, la città da cui viene mia madre.
“Buongiorno Alexis”. La calda voce di mia madre accarezza le mie orecchie e distoglie il mio sguardo dal paesaggio che mi circonda. Ed eccola lì mia madre una donna piccola avvolta da una lunga tunica bianca con ricami rossi dalla cui sommità svettava il suo volto leggermente squadrato, il naso aquilino, una folta chioma di capelli neri e quegli occhi verdi che sembravano scrutare ogni cosa potendone intuire tutti i segreti, quasi fossero delle parole di un libro aperto. A incorniciare tutto ciò una folta chioma di capelli neri come le ali di un corvo.
“Mamma! Come mai sei venuta a trovarmi?”
“Te lo sei forse dimenticato? Oggi compi finalmente ventuno anni, sei un adulto a partire da oggi.”
Un sorriso affiora sul mio volto e subito viene imitato da mia madre.
“Beh allora? Che pensi di fare adesso che sei un uomo a tutti gli effetti?”
“Beh ecco non ho le idee molto chiare credo che visiterò l’oracolo di Delfi per chiedergli consiglio.”
Alla parola “oracolo” il sorriso scompare dal volto di mia madre e un lampo di paura, simile a quello che compare negli occhi degli animali quando con le spalle al muro capiscono che non riusciranno a sfuggire alla lancia del cacciatore, appare nello sguardo di mia madre.
“Madre? Ho detto qualcosa che non avrei dovuto?”
Le mie parole sembrano risvegliarla da un incubo, il lampo di emozioni che lampeggiava negli occhi di mia madre scomparve sostituito dal consueto velo di mistero e l’espressione affabile e gioiosa di un attimo prima ritorna sul suo viso.
“Certo caro, se vuoi potrai andare a Delfi ma credimi gli Oracoli, men che meno quello appartenente a quella città, non ti porteranno niente di buono ti diranno solo ciò che tu già sai. Comunque ora devo andare, tieni qualche dracma, vai in città insieme a Timoteo e divertitevi, io e te ci vedremo stasera per festeggiare.”
Detto questo mi stringe la mano e vi lascia scivolare qualche moneta d’argento, dopo di che mi abbraccia e se ne va. Per qualche minuto rimango a guardare la sua figura che si fa sempre più piccola mano a mano che si allontana, quando ormai mia madre non è altro che un puntino sull’orizzonte mi giro e corro verso casa, ansioso di dire a Timoteo che oggi avremmo potuto trascurare i campi per dedicarci, a modo nostro, alla venerazione di Dionisio.
Capitolo 1, Tebe, 27 anni prima (parte seconda)
Ripenso all’insolito lampo di paura apparso negli occhi di mia madre all’udire la parola Oracolo. Non ricordo di averla mai vista venir colta da un terrore così profondo da rimanere impotente, senza avere la forza di reagire, quasi fosse un grande guerriero che nonostante abbia combattuto con onore e coraggio deve arrendersi alla superiorità del nemico e accogliere l’arrivo del freddo abbraccio di Thanatos senza poter fare nulla.
Mentre la mia mente vaga, però, il mio corpo rimane saldamente ancorato a terra, o meglio alla radice nella quale il mio piede si incastra facendomi ruzzolare a terra e riportandomi alla dura realtà. Prima ancora però che abbia il tempo di rialzarmi una grossa risata attira la mia attenzione, alzo il capo e davanti a me ritrovo Timoteo, che sembra trovare infinitamente divertente la mia caduta.
“Beh, hai perso forse qualcosa e hai deciso di avvicinarti al terreno per cercarlo?” mi dice continuando a ridere sguaiatamente.
“No, stavo continuando l’ormai senza speranza ricerca della tua simpatia, ma credo che nemmeno Gea abbia il potere di ritrovarla, forse perché l’hai smarrita da lungo tempo o più probabilmente perché non è mai esistita.” rispondo.
“Invece di restare fermo a fissarmi ridendo come fossi un animale che gira in tondo cercando di mordersi la coda, perché non mi aiuti a rialzarmi? Se lo fai potrei anche decidere di condividere con te il dono per la mia maturità”, dico aprendo il palmo e rivelando al sole mattutino le dracme argentate donatemi poco prima.
Alla prospettiva di una giornata passata a godere dei doni di Dioniso ed Eros senza dover sborsare i soldi duramente guadagnati nei campi il volto di Timoteo si illumina come il cielo a mezzogiorno e l’espressione di gaudio già presente sul suo viso lascia il posto a una vera e propria estasi.
“Bene, bene; questo sì che è un risvolto decisamente positivo della giornata e io che pensavo avrei dovuto passare l’intero pomeriggio ad arare i terreni a Sud.” dice porgendomi la mano per aiutarmi a rialzarmi.
Allungo il braccio e nel momento in cui i nostri palmi si toccano la mano di Timoteo si chiude in una morsa e in un istante mi ritrovo stretto in un rude abbraccio. Rimango in balia dello stupore di fronte a questo gesto e per un istante la mia mente indaga sul motivo per cui un’azione tanto semplice assuma per me un significato tale da spingermi alla commozione, tuttavia è per la ragione impossibile giungere alla risposta che, almeno per ciò che concerne le emozioni, appartiene all’anima.
Tuttavia il momento termina, così com’era iniziato, in un istante lasciando immutato il mondo circostante ma gratificato e gaudente il mio animo. Timoteo si allontana da me e per un attimo il suo sguardo indugia su di me osservando come, nel corso degli anni, il tempo abbia cambiato il mio corpo trasformandomi nell’uomo che sono ora.
“Beh, ragazzo, non so veramente cosa dirti, se non che sono orgoglioso di poterti finalmente definire un uomo. Ora sarai tu a tenere la penna con cui scriverai la storia della tua vita: sono molto curioso di vedere che tipo di racconto ne uscirà fuori; però, se ti posso dare un consiglio, come prima pagina della tua vita adulta ci vedrei bene una sbronza colossale insieme a me, che ne pensi?”
“Che ne penso, Timoteo? Credo che sia un proemio degno dell’Iliade”.
“Allora che cosa stiamo aspettando? Muoviamoci e che Zeus ci fulmini se torneremo prima che l’alba sorga nuovamente”. Detto questo ci voltiamo e ricominciamo a percorrere il sentiero sterrato attraverso i campi. Mentre camminiamo tutto intorno a me scorre il paesaggio che per 21 anni ha fatto da sfondo a ogni mia giornata, i grandi campi di grano tanto splendenti nella luce del pomeriggio da fare sembrare le colline avvolte da un manto dorato su cui, di tanto in tanto, vi sono dei ricami, le casupole dei contadini, e a ornare tutto ciò sottili fili di fiori, piccoli fiumi d’ogni colore che rifulgono di piccoli diamanti di rugiada posti sui loro fondali. Purtroppo tutta questa bellezza, o forse la mia disattenzione, mi portano a non accorgermi di essere arrivato dinnanzi alle mura della città e mi ritrovo bruscamente riportato alla realtà da un vecchio mercante evidentemente importunato nel suo percorso dalla mia presenza nel mezzo del viale.
“Sempre con la testa altrove, eh, Alexis? – mi dice Timoteo – Dai forza ritorna in te ed entriamo in città “. Dopodiché si volta e attraversa la porta delle mura, entrando a Tebe.
Per un attimo lascio che il mio sguardo vaghi sulle imponenti costruzioni in pietra su cui i soldati montano la guardia, scrutando dall’alto la massa di persone sottostante; ma la prospettiva di festeggiare è viva nella mia mente e non lascia il tempo di indugiare, dunque anche io mi dirigo verso la porta e dopo aver attraversato un breve tratto di oscurità sotto alla volta del passaggio rimango per un attimo accecato dalla luce della magnificente città che si dispiega dall’altra parte.
Capitolo 1, Tebe, 27 anni prima (parte terza)
Quando Timoteo e Alexis, dopo il loro incontro, hanno ormai raggiunto la città di Tebe.
Riapro gli occhi e la visione che si presenta ai miei occhi è tanto vasta quanto magnifica: davanti centinaia di persone percorrono la strada lastricata sotto i miei piedi, uomini e donne estremamente diversi tra loro, alcuni sono cittadini di ritorno alle proprie case, altri invece stranieri portati in città dai propri interessi, sia che questi siano di nobili o vili fini.
Mi volto verso Timoteo e i nostri sguardi si incontrano, nessuno dei due proferisce parola, ma entrambi sappiamo dove ci dirigeremo: alla locanda dell’Oplita Barcollante.
Senza indugio iniziamo a percorrere la strada principale e, mentre camminiamo, la mia mente già va ripercorrendo i pochi ricordi legati a quel locale posto sulla parte destra di una piccola viottola poco distante dall’agorà; una memoria in particolare giunge alla mia mente, quella di un incontro avuto alcuni anni prima quando, durante una notte temporalesca, con la scusa di ripararmi dall’ira di Zeus, avevo atteso l’alba nella locanda.
Inizialmente ricordo di non esser stato molto tranquillo all’idea di restare da solo in un luogo ove, come suggerisce il nome stesso, i vecchi soldati ormai congedati passavano il proprio tempo inneggiando alle proprie gesta passate e, grazie all’ausilio del vino, pronti a difendere le proprie storie, spesso inverosimili, anche con la violenza.
Quella notte la locanda era tuttavia deserta, nessun’avventore aveva avuto l’ardire di sfidare la tempesta in nome di una caraffa di vino.
Presa una coppa e una brocca piena di nettare dionisiaco per riempirla ogni qual volta questa si fosse svuotata, mi ero diretto verso il tavolo ove eravamo soliti sederci io e Timoteo, nell’angolo posto all’estrema destra del locale.
Tuttavia mentre mi avvicinavo, già pregustando il sapore asprigno del vino di bassa qualità, mi accorsi della figura ammantata d’ombra che era rimasta fino a quel momento invisibile ai miei occhi. In principio ero intimorito, tuttavia mi dissi che non sarebbe successo niente e, preso un grande respiro e sfoderato un sorriso accomodante, mi diressi con decisione verso l’oscuro personaggio.
Mi sedetti proprio a fianco a lui, ma questi rimase chiuso in un silenzio mortale, senza distogliere lo sguardo dall’oggetto che teneva in una mano, continuando a girarlo e rigirarlo all’interno del palmo.
Per lungo tempo l’uomo rimase rinchiuso nella sua armatura e, dunque, non potei fare nient’altro che osservarlo attentamente, sperando di poter leggere attraverso i suoi lineamenti una storia che mi potesse indicare il tipo d’uomo con cui avevo a che fare.
Ben presto mi resi conto di come quel corpo, che inizialmente non avevo notato, era da vicino una figura estremamente imponente, resa ancora più impressionante dai tonici muscoli celati al di sotto di una pelle di un colorito estremamente pallido, quasi cadaverico.
Tuttavia non era il corpo dello sconosciuto avventore l’oggetto della mia attenzione, ma il suo volto.
Il viso di quell’uomo era tanto bello quanto inquietante, terribile e magnifico al tempo stesso, come fosse uno splendido tempio che cade sotto il peso degli anni ma che, nel momento in cui la sua bellezza si unisce all’effimera magnificenza della distruzione, raggiunge il proprio massimo splendore.
di Gioele Valesini, 2 Quadriennale
Capitolo 1, Tebe, 27 anni prima (parte quarta)
Quando Timoteo e Alexis sono nella taverna dell’Oplita Barcollante e Alexis avvicina uno straniero.
Il viso di quell’uomo era tanto bello quanto inquietante, terribile e magnifico al tempo stesso, come fosse un magnifico tempio che cade sotto il peso degli anni ma che nel momento in cui la sua bellezza si unisce all’effimera magnificenza della distruzione raggiunge il proprio massimo splendore.
Un dettaglio in particolare contribuiva a rendere quello che altrimenti sarebbe stato uno splendido ritratto in un’immagine quasi grottesca, infatti mentre uno degli occhi del misterioso sconosciuto era di un vivace azzurro cielo il suo gemello era di un nero talmente profondo che persino la notte più scura sarebbe impallidita a suo confronto, l’iride e la pupilla unite in un’unica pozza di pura oscurità, per certi versi simile a quelle presenti negli occhi di mia madre.
Tuttavia mentre quelli di quest’ultima sembrano celare al proprio interno segreti e misteri di un tempo ormai passato gli occhi di quello sconosciuto sembravano contenere le memorie di un passato infinitamente doloroso, i cui ricordi continuavano a perseguitare il proprio contenitore, rendendogli impossibile abbandonare il fardello che per troppo tempo era stato sostenuto dall’anima.
Proprio mentre quest’intuizione raggiungeva la mia mente il misterioso avventore distolse lo sguardo dall’oggetto che era stato fino a quel momento il centro delle sue attenzioni, fissandolo invece sui miei occhi, trasmettendomi in un solo attimo un tale carico di sofferenza e angoscia da inchiodarmi al suolo e rendendo, sotto il loro peso, impossibile ogni movimento.
E proprio nel momento in cui pensavo di non poter sopportare oltre un tale fardello, lo Sconosciuto parlò.
“Qual è il tuo nome, ragazzo?” mi chiese. La sua voce era estremamente profonda con dei toni talmente bassi da rendere quasi impossibile carpire quanto stesse dicendo.
La saliva mi riempiva la bocca ed il sudore mi scivolava lentamente sulla mia fronte, ma non potevo certo restarmene zitto senza rispondere alla domanda di quello sconosciuto avventore, così deglutii e, cercando di mantenere un tono fermo ma al tempo stesso pacato, dissi: “Mi chiamo Alexis, vengo dalle campagne ad ovest della città. Tu invece? Sai, non hai l’aria di essere di queste parti”.
Per qualche secondo lo Sconosciuto rimase in silenzio, quasi nella sua memoria stesse ripercorrendo a ritroso le numerosissime strade di un viaggio ancor più lungo.
Fu questione di pochi secondi al termine dei quali l’uomo sembrò prendere una posizione e una volta che in pochi, rapidi sorsi ebbe prosciugato quanto rimaneva del vino contenuto dalla brocca si schiarì la gola e disse: “Sei arguto ragazzo… cogli nel segno affermando che io sia uno straniero, ma non sono in grado di dirti da dove io provenga, troppo tempo sono stato lontano da casa e ormai null’altro che i ricordi mi sono rimasti del luogo che mi fu natale”.
Al sentire queste parole così piene di tristezza subito nella mia gola si formò un nodo, non riuscivo a tollerare l’idea di quanta amara dovesse essere una vita priva di un’origine, di un posto sicuro in cui tornare per trovare conforto e riparo dalle avversità di una vita spesso troppo dura.
Tuttavia, seppur con la gola ostruita, riuscii a porre a quell’uomo misterioso un’altra domanda, sorta spontanea nella mia mente ed alimentata dalle parole dello sconosciuto: “Qual è il tuo mestiere?”
Gioele Valesini, 2 A Quadriennale
Condividi questo articolo: